Come mai il valore della magnitudo di un terremoto viene modificata nelle ore successive ad un evento sismico, risultando così diverso dal dato iniziale?
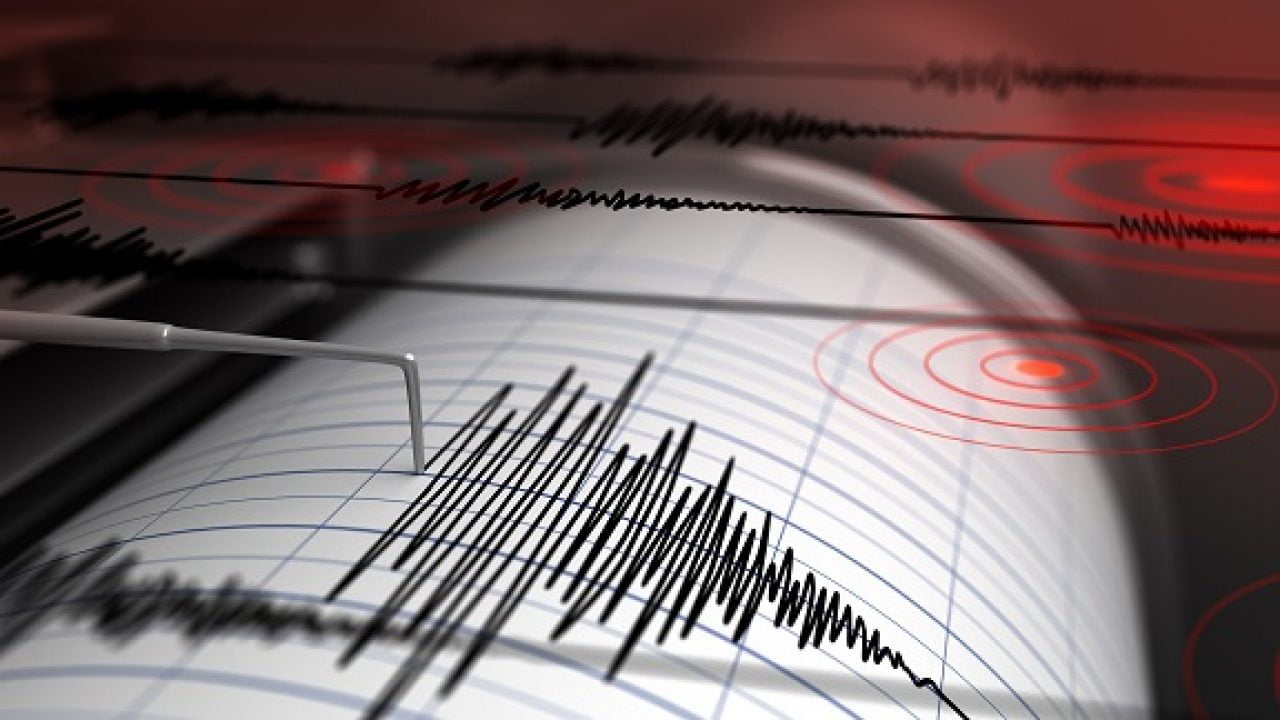
Quando si verifica un terremoto, si è interessati a definire immediatamente, sia le coordinate spaziali dell’epicentro, che il valore della magnitudo, così da poter comprendere e delimitare l’area interessata dal sisma stesso. Durante un terremoto si ha il rilascio di energia elastica, la quale si propaga all’interno del nostro pianeta sottoforma di onde di volume (P ed S) e onde superficiali (Rayleigh e Love).

Quando tali segnali raggiungono la superficie terrestre, questa incomincia a muoversi e l’entità di tali scuotimenti dipende essenzialmente dalla quantità di energia rilasciata dalla sorgente, dalla sua profondità e dai fenomeni di attenuazione o di amplificazione che il segnale sismico può subire lungo il suo percorso.La quantità di energia sismica rilasciata dalla sorgente la si può calcolare solamente attraverso la definizione del valore della magnitudo. Molto in generale possiamo far riferimento ad almeno due diverse tipologie di magnitudo: la “magnitudo locale” (Ml) e la “magnitudo momento” (Mw).

La prima venne formulata da Charles Richter all’inizio del ‘900 e corrisponde ad un’equazione logaritmica di tipo
empirico, sviluppata prettamente per i sismi che avvenivano in California. Questa consente di calcolare la magnitudo misurando lo spostamento del pennino del sismografo rispetto alla posizione zero e confrontando tale valore con quello di riferimento (generalmente si prende come riferimento lo spostamento del pennino del sismografo generato da un sisma distante 100 km dalla stazione considerata). Un problema associato a questo tipo di magnitudo riguarda essenzialmente il tipo di strumentazione utilizzata e il valore assunto dai coefficienti presenti in tale equazione, che dovrebbero essere calibrati per ciascuna area da analizzare.

Ad esempio l’INGV, avendo a disposizione una fitta rete di sismografi, utilizza questo metodo costantemente ottenendo con velocità e buona accuratezza il dato sulla magnitudo. Quindi è facilmente intuibile, che se il terremoto avviene in Italia e i dati che vengono analizzati nei primi minuti post sisma, riguardano i sismografi ad esempio del centro di sismologia americano, sicuramente ci saranno degli errori che dovranno essere corretti nel tempo.
Per evitare il problema sulla corretta calibrazione dei coefficienti, nel 1977 il sismologo giapponese Hiroo Kanamori propose la cosiddetta “magnitudo momento“, che si basa sul calcolo del momento sismico del terremoto raccogliendo le frequenze proveniente da un terremoto a distanze anche molto elevate. Questo parametro dipende da caratteristiche proprie della zona di faglia tipo l’area interessata da essa, l’entità dello scivolamento fra i due blocchi e il valore del modulo di rigidità delle rocce interessate dalla faglia stessa. Quindi, si può facilmente comprendere che i valori forniti dalla Mw sono molto più affidabili di quelli forniti dalla magnitudo locale di Richter, ma ha tempistiche più lunghe.
Infine, per quanto riguarda i fenomeni di attenuazione o di amplificazione dei segnali sismici, questi sono molto importanti perché modificano completamente le caratteristiche proprie del segnale stesso. Quindi in base al tipo di rocce presenti (cioè se sono rocce dure o terreni sciolti) e all’andamento della superficie topografica (cioè se essa è piatta oppure corrisponde ad un rilievo), la risposta sismica del sito analizzato cambierà completamente. In base al tipo di fenomeno prevalente, si potrebbero avere dei casi estremi in cui si ritrovano aree completamente distrutte contigue ad aree illese. Come conseguenza delle differenti tipologie di rocce è da considerare la quantità di accelerazione che il suolo può avere in termini di scuotimento dello stesso.
**Articolo redatto dal Dott. Salvatore Bruno e Cipriano Clemente




